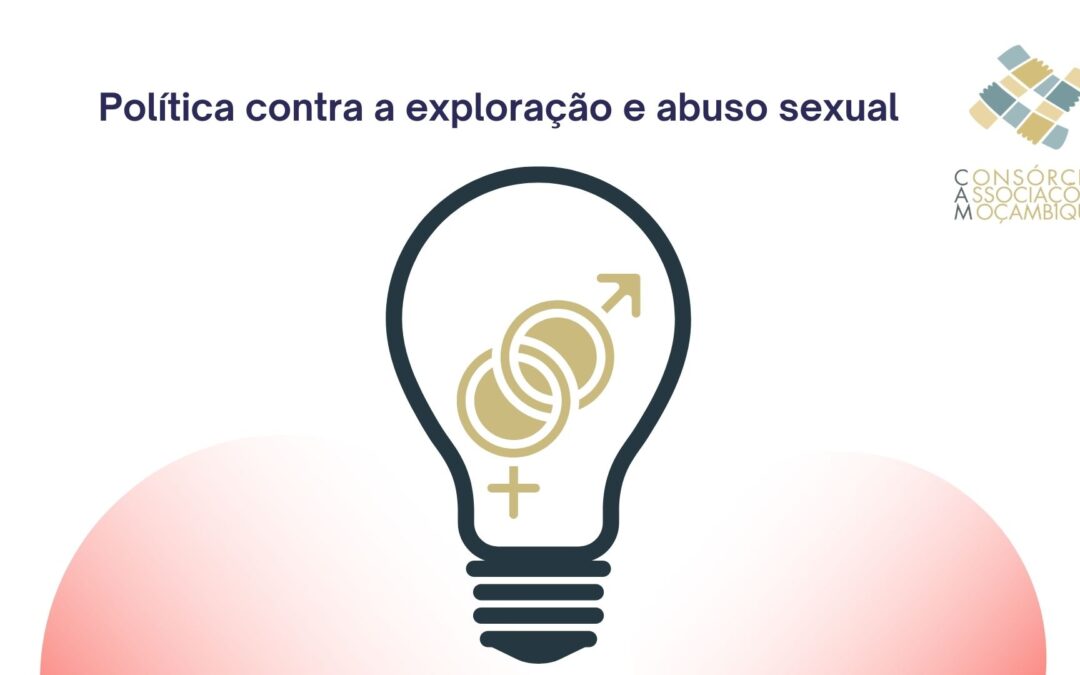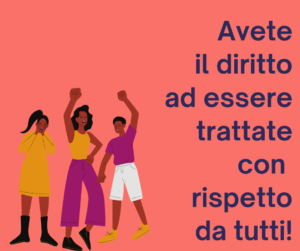Coinvolgere uomini e ragazzi per promuovere la parità di genere, l’esempio dei “club degli adolescenti”
Affrontare le norme sociali e porre fine alla violenza di genere: il prezioso ruolo dei club per ragazzi in Mozambico
Sofala, Mozambico – Almeno tre volte al mese, diversi gruppi di ragazzi e giovani maschi adolescenti, di età compresa tra i 13 e i 20 anni, si incontrano per discutere di argomenti che vanno dalla sessualità, al genere, dai matrimoni precoci alla mascolinità tossica. Qual è l’obiettivo? Creare un cambiamento positivo nelle loro comunità. Gli incontri si tengono solitamente in cortili scolastici, nella provincia di Sofala, contribuendo ad attrarre ancora più giovani a partecipare.
Che la sua scuola a Beira sia uno spazio inclusivo libero dalla violenza di genere (GBV) è uno dei sogni del quattordicenne Cleiton Adriano. L’adolescente frequenta la prima media e conduce attività di sensibilizzazione con i suoi coetanei. Nell’agosto 2022, Cleiton Adriano ha ricevuto una formazione sulla GBV nell’ambito di un progetto di UNFPA per migliorare la salute riproduttiva, materna e adolescenziale nella provincia di Sofala, con i fondi della Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Realizzato dal partner di UNFPA, Consorzio Associazioni con il Mozambico (CAM), in 14 scuole dei distretti di Beira, Dondo, Nhamatanda e Búzi, il progetto promuove l’emancipazione femminile e contribuisce a cambiare positivamente comportamenti, atteggiamenti e pratiche maschili, coinvolgendo ragazzi e giovani uomini a rispondere – e mitigare – la violenza di genere nelle loro scuole secondarie.
All’inizio del 2022, un totale di 14 membri del “club dei ragazzi” [rapazes, ovvero ragazzi maschi n.d.T.] sono stati formati come leader per guidare le discussioni con gli 84 membri del “club dei ragazzi adolescenti”. Tali corsi di formazione sono stati realizzati con il supporto tecnico delle Direzioni Provinciali dell’Istruzione e della Sanità.
Due dei membri che si sono uniti al club sono Leonel e Benilton, entrambi studenti delle elementari. Leonel ricorda che era solito fare il prepotente con le ragazze, in particolare le sue compagne di classe a scuola: “Dopo aver partecipato alle sessioni, ho capito che le mie idee erano sbagliate e ora voglio condividere informazioni positive con i miei colleghi e la comunità”, ha commentato Leonel. Benilton ha condiviso che quando si è unito alle sessioni guidate dal suo facilitatore, Cleiton, ha cambiato il suo comportamento e ora i suoi genitori sono molto orgogliosi di lui. “Le sessioni non solo hanno cambiato la mia vita, ma grazie a loro ho compreso e aiutato a denunciare casi di violenza di genere nella mia comunità”.

Coinvolgere uomini e ragazzi per promuovere la parità di genere
Ad oggi, i “club dei ragazzi” hanno raggiunto circa 434 adolescenti e giovani, insieme ad altre sessioni di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità. “Uno dei grandi risultati è stato il cambiamento di mentalità di alcuni genitori e tutor che credevano che il coinvolgimento dei propri figli maschi in attività che affrontano la violenza di genere e la salute sessuale e riproduttiva avrebbe compromesso la loro mascolinità”, ha condiviso Cremilda Gravata, una delle 14 insegnanti formate in GBV nell’ambito del progetto KOICA e che sostiene il club dei ragazzi della sua scuola secondaria. Adriano Cerveja, della Direzione provinciale dell’Istruzione di Sofala, sostiene l’idea che i ragazzi (maschi) abbiano svolto un ruolo cruciale nella denuncia della violenza di genere, del bullismo e di altre pratiche dannose. Hanno anche indirizzato gli adolescenti a servizi sanitari a misura di giovane per la pianificazione familiare e altri supporti, informazioni e consigli relativi alla salute.
Dal 2022, il progetto pluriennale finanziato da KOICA consente a ragazzi come Cleiton nella provincia di Sofala di educare e ispirare i loro coetanei a sfidare gli stereotipi sulla mascolinità e il comportamento a rischio e a rafforzare il loro ruolo nella promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere.

Diffondere messaggi positivi sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle ragazze è stato uno dei miei compiti quotidiani a scuola”, ha affermato Cleiton, osservando che uno dei suoi più grandi desideri è “diventare un agente di cambiamento positivo nella mia comunità”
“Sono riuscito a convincere alcuni membri a unirsi al club dei ragazzi e ora sono orgoglioso di vedere i loro cambiamenti trasformativi nel comportamento, nelle azioni e nella mentalità“, ha osservato Cleiton.

“Diffondendo messaggi sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere e sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, i ragazzi hanno apportato effettivi cambiamenti comportamentali a scuola”, condivide Cremilda Gravata
Dall’articolo “Combater as normas sociais e acabar com a violência baseada no género: o valioso papel dos clubes de rapazes em Moçambique” pubblicato sul sito web di UNFPA Mozambique.
Traduzione dal portoghese a cura di Martina Seppi.
Foto in alto – Consorzio Associazioni con il Mozambico.
Foto nel testo – UNFPA Mozambique.
Per saperne di più sul progetto vedi anche: Un nuovo progetto per contrastare ogni forma di violenza di genere